Monza 28 novembre 2015
Corso di formazione per amministratori locali promosso dalla federazione provinciale del PD di Monza e Brianza e dalla Fondazione E. Quercioli.
Unioni e Fusioni dei comuni come scelta strategica
In primo luogo vi voglio ringraziare per questo invito. Io non ho titoli accademici e non ho più alcun ruolo istituzionale o di partito che giustifichi questo invito. Sono, questo sì, un testimone appassionato di tutto ciò che riguarda le autonomie locali per le quali mi sono impegnato e, nel limite delle possibilità che mi sono offerte, continuo ad impegnarmi.
Come forse sapete sono stato sindaco di Pesaro per 12 anni, dal 1992 al 2004, e presidente nazionale della Lega delle Autonomie Locali dal 2000 al 2010, faccio questo riferimento autobiografico perché mi serve ad introdurre alcune premesse che ritengo fondamentali per il tema che dobbiamo trattare.
Non era un periodo facile, oggi gli amministratori si trovano a gestire situazioni davvero difficili, ma anche allora non si scherzava se è vero come è vero che per far fronte al rischio “bancarotta” in una notte il governo Amato fu costretto a mettere le mani nei conti correnti dei risparmiatori italiani e tutte le mattine inevitabilmente leggevamo il giornale per sapere chi era stato arrestato.
In quel periodo però avevamo di fronte una visione, un progetto frutto di un pensiero, a lungo cresciuto nel nostro paese ma sempre rimasto minoritario , che aveva trovato un nuovo vigore dalle politiche strategiche di una Europa muova e dalla necessità di uscire dalle secche drammatiche in cui l’Italia era finita. Uno scenario che ci sembrava abbastanza chiaro e coerente e su quello ci impegnammo a fondo: al cosiddetto crollo della prima repubblica manifestatosi con tangentopoli pensammo di rispondere con più Europa intesa come risposta alla crisi degli stati nazionali e alla internazionalizzazione dei processi economici ma anche come esempio di politica solida e di amministrazione efficiente che sembravano essere i tratti salienti di un modo di essere di paesi che con noi condividevano il disegno europeo; più ruolo alle autonomie locali e regionali proprio come l’altra faccia dell’europeismo (pensare globale e agire locale) , come risposta all’esasperato centralismo istituzionale e burocratico che aveva così clamorosamente fatto naufragio mettendo in discussione la stessa democrazia nel nostro paese e come bisogno di assicurare vicinanza fra i processi amministrativi e di welfare alle comunità, più sussidiarietà non solo istituzionale ma anche sociale intesa come maggiore protagonismo della società civile e delle forze sane in essa operanti.
Quel processo ebbe uno sviluppo piuttosto coerente per tutti gli anni ’90 del secolo scorso e portò dei risultati considerevoli in termini di recupero di prestigio delle istituzioni e a riforme di cui la chiave fu più autonomia. Più autonomia sul terreno della fiscalità locale con l’introduzione di imposte per le quali per la prima volta un comune non doveva più qualificarsi solo per la capacità di spesa ma anche per la capacità di reperire le proprie entrate dando luogo a veri e propri patti con le proprie comunità; più autonomia nella gestione delle proprie risorse umane, di organizzazione delle strutture amministrative, più autonomia da sistemi di controllo che non avevano data risultati positivi tali da contenere il fenomeno della corruzione.
Si produssero leggi importanti e infine si giunse, coerentemente ma parzialmente, alla revisione del titolo V della seconda parte della costituzione. L’articolo 114 con la definizione del tutto nuova della Repubblica. L’articolo 117 che per la prima volta declinava le competenze esclusive dello stato e quelle concorrenti fra stato e regioni lasciando un ampio spettro di funzioni “residuali” legislative alle regioni stesse. Era dal 1970 che si attendeva una operazione tanto coraggiosa quanto necessaria per dare compiutezza al dettato costituzionale. L’articolo 118 che definiva in modo netto la competenza amministrativa dei comuni dando un senso chiaro alla sussidiarietà verticale e non senza difficoltà a quella orizzontale. L’articolo 116 che al terzo comma prevedeva forme di autonomia più spiccate per quelle regioni che si fossero dimostrate capaci di gestioni virtuose e l’articolo 119 tanto citato nei convegni quanto disatteso per tutto il lungo periodo che seguì la riforma costituzionale, ovvero il federalismo fiscale e demaniale.
Che dire dell’oggi?
Io direi sinteticamente che oggi l’AUTONOMIA è messa proprio male, attaccata , vilipesa e non difesa. Da diversi anni assistiamo ad un ritorno centralista in grande stile perseguito con insistenza e coerenza e non sembra che le autonomie siano in grado di arginare questo fenomeno in modo efficace e convincente.
Non dimentichiamo il fatto che questo ritorno centralista ha avuto come protagonisti principali i governi di centro destra partecipati paradossalmente dalla Lega Nord dietro i quali si è prima salvata e poi ampiamente riciclata buona parte di quella classe dirigente della prima repubblica che, insediata in ruoli di sottogoverno o di alte burocrazie ministeriali subì quei cambiamenti e non lasciò nulla di intentato affinché il processo riformatore si bloccasse e cominciasse un deciso ritorno al passato.
Questo ci dice una cosa chiara: storicamente fin dalla nascita dello stato unitario nazionale la battaglia per l’ autonomia non è mai stata neutra e ha avuto sempre un connotato progressista contrapposto ad un centralismo che corrispondeva ad un preciso blocco sociale e di potere: il grande capitale, le burocrazie che ad esso rispondono, un modello di politica tendenzialmente autoritario. Lo è stato con il modello sabaudo, con il modello fascista, e poi sotto le paure della guerra fredda anche con i vari modelli in cui si è espressa la centralità del potere democristiano. Ed anche la sinistra, in particolare quella massimalista e statalista per decenni non ne colse la straorinaria forza riformatrice .
Sia chiaro una visione dell’assetto istituzionale fortemente centralista è del tutto legittimo, non è un golpe antidemocratico, ma corrisponde ad una determinata visione del potere, una visione che può anche dare risultati temporanei ma che alla lunga, questo si evince dalla nostra storia nazionale, non funziona ai fini della creazione di un sistema paese efficace e e di una responsabilità civica diffusa.
Facciamo bene quindi a guardare alle responsabilità, che sono evidenti, delle classi dirigenti locali rivelatesi non sempre all’altezza del compito , ma guai a dimenticare che dall’altra parte non ci sono forze oggettivamente dedite al bene del paese ma forze che rispondono a certe logiche di potere politico ed economico.
Per questo la prima domanda che le classi dirigenti locali devono farsi è se intendono battersi per essere parte del governo del sistema oppure acconciarsi ad essere esecutori più o meno passivi di linee politiche che non li coinvolgono e che li trattano poco più che alla stregua di numeri. E di numeri infatti costantemente si è cominciato a parlare, numeri connessi a ipotetici costi: Il numero del personale politico impegnato nelle istituzioni locali, il numero dei comuni, delle comunità montane, ora delle regioni ecc.
L’attacco alla autonomia è cominciato con una campagna contro le comunità montane che ad un tratto sembrarono essere tutte collocate in riva al mare. Ma ancora prima l’attacco era stato portato per la chiusura dei consigli di circoscrizione nelle città sotto i 250 mila abitanti ovvero laddove paradossalmente costavano pochissimo a fronte di una funzione importante sul piano democratico. Si attaccarono le comunità montane senza neppure fermarsi a pensare che in vero si trattava di esperienze di gestione in unione di politiche e servizi propri dei comuni, cioè si trattava, in forme inadeguate quanto si voglia, di esperienze che oggi si chiede che siano più diffuse e che proprio per questo vengono incentivate.
Poi è arrivato l’attacco alle province, questione decennale, ma affrontata non dal punto di vista della esigenza di dotarsi di livelli di governo di area vasta più adeguati alla nuova dimensione territoriale delle politiche e dei servizi ma sempre dal punto di vista del costo del personale politico. La conseguenza è che ora ai consigli e alle giunte provinciali si sono sostituite le conferenze dei sindaci, ma l’organizzazione e il finanziamento dei servizi che facevano capo alle province rimangono sostanzialmente identici al netto di alcune funzioni che le regioni hanno colto l’occasione di riprendere sotto la loro diretta responsabilità amministrativa in barba alla autonomia e all’art.118 della Costituzione. Di certo è aumentata la debolezza politica dei territori, è aumentata la confusione nella gestione, e a fronte dei tagli promossi dalle ultime leggi di stabilità è aumentato il rischio fallimento per tutte le province.
Ma che dire del dibattito più complessivo sulle questioni istituzionali e costituzionali.
Apparentemente sia l’abolizione del bicameralismo paritario e la creazione di un Senato delle regioni e delle autonomie si muove nella direzione, per me giustissima, tracciata dal nuovo titolo V approvato nel 2001, anche la cancellazione delle province dalla Costituzione sembra dare compimento ad un decennale dibattito fra autonomisti sul mitico “ente intermedio”. Però se andiamo a fondo c’è qualcosa che non torna per chi guarda a questo dibattito con l’occhio delle autonomie.
Intanto l’impianto costituzionale connesso anche alla legge elettorale porta ad una forte sottolineatura del ruolo del Governo e del Presidente del Consiglio un tema che non è indifferente rispetto ad una visione autonomistica la quale richiede certamente uno stato centrale forte per evitare di dar luogo all’anarchia dei territori ma non nel senso di un Governo centrale invasivo, che interviene a gamba tesa dentro alle funzioni dei comuni o dentro al potere delle regioni secondo calcoli politici contingenti. Ad esempio è del tutto apprezzabile che il Governo intenda incentivare con risorse aggiuntive la messa a norma delle scuole, per nulla apprezzabile è che la lista delle scuole ammesse al finanziamento esca da Palazzo Chigi. E’ per nulla accettabile che il patto per la salute sottoscritto nel 2014 da due livelli istituzionali costituzionalmente legittimati nella loro autonomia venga unilateralmente rimesso in discussione in assenza di una condizione oggettivamente peggiorata dello stato delle finanze del paese , ma per il solo fatto che il Governo intende spendere quei soldi in un altro modo. L’uso della decretazione d’urgenza, i tempi certi che il governo può chiedere al Parlamento per l’approvazione di propri provvedimenti, la clausola di supremazia facilmente attivabile, sono in questo contesto aspetti ambivalenti, coltelli a due lame che possono ulteriormente spingere verso il centralismo e verso la supremazia indiscussa dell’esecutivo nazionale.
Lo stesso Senato delle regioni e delle autonomie viene alla luce in un contesto a dir poco contraddittorio. Io ho sempre pensato e lo penso ancora, che è proprio dei sistemi autonomisti avere dei settori in cui la legislazione è concorrente fra Stato e Regioni ed ho sempre pensato che quello fosse lo spazio istituzionale che necessariamente il Senato delle regioni e delle autonomie dovesse andare ad occupare.
Si è detto che è un sistema che non ha funzionato. Secondo me le ragioni del cattivo funzionamento stanno in parte in un problema di pochezza politica di alcune regioni , in un altra parte nelle resistenze centraliste mai datesi per vinte, ma in massima parte nella assenza di una camera che con la partecipazione diretta di regioni e comuni partecipi al processo legislativo. Ora noi diamo il via finalmente a questo Senato delle regioni e delle autonomie locali ma guarda caso gli togliamo il materiale su cui deve lavorare ovvero i settori di concorrenza legislativa fra regioni e stato centrale e tanto per non smentirsi il Parlamento ritoccando l’art.117 della Carta ha ulteriormente spinto nella direzione di togliere potestà legislativa alle regioni.
Parallelamente se sembra coerente con un impianto autonomista il disegno di ridurre il numero delle prefetture e degli uffici periferici dello stato, cosa su cui ci battiamo da 15 anni, è meno coerente che questo avvenga quando le funzioni dello Stato centrale si tende chiaramente a farle aumentare.
Le cose non vanno meglio se poi dal livello istituzionale e costituzionale passiamo alla dimensione fiscale, della pubblica amministrazione, del modello di welfare, delle politiche di sostegno all’economia. L’abolizione dell’imposta locale sulla proprietà della prima casa è per me non solo profondamente ingiusta ma è del tutto contraria ad ogni seppur flebile visione autonomista. Cos’è l’autonomia se non la possibilità di stabilire un patto sociale con la propria comunità per cui ad un prelievo fiscale corrisponde una verifica dei servizi resi. E non risolve il fatto che il mancato incasso del comune venga totalmente coperto dallo Stato. Non solo perché questa restituzione fotografa una situazione togliendo appunto al comune l’autonoma possibilità di agire sulla flessibilità che quella imposta gli consentiva, non solo perché finisce per penalizzare l’ente che era stato più attento a non utilizzare tutta la potenzialità fiscale che l’imposta gli consentiva, ma perché spezza alla radice la relazione virtuosa fra ente e contribuente che invece va tenuta ben viva. Per quanto riguarda poi la pubblica amministrazione ridurre il possibile reimpiego delle risorse risparmiate con i pensionamenti ad un misero 25% significa paralizzare strutture, condannarle all’invecchiamento e al ritardo tecnologico. Infine scavalcare le istituzioni locali stabilendo una relazione sempre più giocata sui “bonus” in merito a politiche di sostegno alla occupazione, alla impresa, alla cultura, vuol dire colpire in radice l’idea del governo autonomo delle comunità in nome di una relazione diretta fra Governo imprese e cittadini.
Io credo che sia sbagliato e soprattutto sia un sistema destinato a non funzionare, un sistema che deresponsabilizza, non contribuisce ne a creare una classe dirigente diffusa ne ad incrementare la cultura di una cittadinanza attiva.
Per non dire della insana passione che sembra aver contagiato un po tutti per i commissariamenti. Questa idea che le cose si risolvono meglio se si eliminano le responsabilità istituzionali democraticamente legittimate mettendo il potere in mano ad uno solo non può che produrre disastri.
Ma perché siamo arrivati fin qui? Come una stagione autonomista è potuta ripiegare in queste situazioni? Una autocritica si impone. Una autocritica accompagnata da una nuova progettualità.
Le classi dirigenti locali hanno una grossa responsabilità. Ma parlo di classi dirigenti locali e non solo di amministratori con cognizione di causa. Può anche esserci stato qualche sindaco che dopo l’elezione diretta ha pensato di far da se, di svolgere la funzione del dominus, dell’uomo solo al comando. Ma per i più la scomparsa dei partiti e la dissoluzione di qualsiasi progettualità politica condivisa ha significato precipitare in una drammatica solitudine. Questo aspetto non è evidenziato come meriterebbe. Un tempo nei diversi incontri che mi è accaduto di tenere, io facevo questo esempio e ve lo ripropongo pari pari oggi: se i sindaci dei piccoli comuni toscani hanno avuto negli anni ‘50 e ‘60 la forza di resistere alla grande spinta della speculazione immobiliare e salvare uno dei paesaggi più belli del mondo che oggi rappresenta un capitale anche economico straordinario, non è solo perché erano contadini, operai, intrisi dell’amore per quella terra ma perché alle spalle avevano un partito dove si discuteva di piani regolatori, di piani particolareggiati dei nostri centri storici, di cultura; perché la politica aveva a che fare con un pensiero condiviso che a sua volta aveva a che fare anche con storici, urbanisti, artisti e tutto questo era un patrimonio di pensiero che arrivava anche nella periferia rappresentata dai nostri mille e mille comuni polvere. E’ difficile immaginare una ripresa della funzione amministrativa senza una ripresa della funzione politica e dei partiti, modernizzati quanto si vuole, ma pur sempre partiti.
Oggi il rischio è che i nostri sindaci, i nostri presidenti di regione, piegati dalla emergenza e immersi in questo vuoto politico, rinuncino ad aspirare ad essere classe dirigente nazionale, riducendo la loro ambizione di essere parte del governo del sistema paese a pura amministrazione quotidiana. Sarebbe una perdita secca per l’Italia e un ulteriore colpo alla fragile democrazia nazionale.
E’ necessaria una nuova progettualità e la crisi che stiamo vivendo ne offre i capisaldi fondamentali.: Identità, Democrazia, Welfare, Sostegno allo Sviluppo.
E’ a partire da questi capisaldi che dobbiamo inserire il cuore della questione che oggi discutiamo.
Siamo drammaticamente in ritardo sulla questione delle Unioni e delle Fusioni dei comuni perché ci è sfuggito, o meglio non è stato elaborato e condiviso a sufficienza, il nesso strategico di questi strumenti con le risposte possibili alle questioni che la crisi non solo finanziaria degli enti locali ci pone. E anche ora che le esperienze di Unione e le Fusioni crescono di numero anche sotto la spinta dell’obbligo a mettere insieme le funzioni per i comuni più piccoli, a me pare che per lo più vengono sostenute con argomenti che rimandano solo ed esclusivamente ad una questione di disponibilità di risorse finanziarie, di sblocco del patto di stabilità, di possibili investimenti.
Vi è su tutta questa questione una responsabilità molto seria dell’ANCI che per anni ha accarezzato il piccolo e bello senza spingere gli amministratori locali ad una riflessione aggiornata sulla realtà che si trovano a governare. E le stesse regioni non hanno incentivato il processo in una sorta di demenziale “divide et impera” che dire autolesionistico è dire poco.
Ad oggi le Unioni dei comuni in Italia sono 438 e vi aderiscono 2318 comuni. Meno del 30% dei comuni è organizzato in Unioni. Il dato delle Fusioni è ancora più sconfortante, esse sono 61 e sono il frutto della fusione di 158 comuni. Il dato è ancora più grave se si passa a considerare che quasi il 60% delle Unioni organizza una popolazione inferiore ai 15.000 abitanti e solo il 10% delle Unioni supera i 50.000 abitanti. Eppure è noto che per alcuni servizi, come l’anagrafe, i servizi tecnici, la pianificazione e progettazione urbanistica il punto di svolta affinché l’ufficio possa dirsi efficiente è sopra i 100.000 abitanti sia per la piena espressione professionale del personale, sia per il pieno utilizzo delle tecnologie oggi disponibili. In Lombardia le Unioni dei comuni sono appena 66 e organizzano 232 comuni e di queste solo 5 superano i 15.000 abitanti.
Ma non voglio cadere nel rischio che ho detto di voler criticare, ovvero di ridurre tutto a una questione di numeri. Andiamo alla sostanza e proviamo a toccare le quattro questioni strategiche che ho sopra accennato.
Identità. E’ uno dei cavalli di battaglia che si frappongono a Unioni e Fusioni. Premetto che si tratta di questione molto seria perché l’identità locale è un fattore potentissimo di coesione. Ma di quale identità stiamo parlando? In vero a mio avviso le grandi trasformazioni sociali, economiche, culturali, tecnologiche hanno stravolto l’identità dei luoghi e se esiste un tema identitario esso consiste nella necessità di ricostruire una identità perduta. Pensate a quante famiglie vivono in un luogo, lavorano e la zona industriale è sita in un altro luogo, mandano i figli a scuola in un polo scolastico intercomunale collocato in un terzo luogo, e per svagarsi, fare la spesa o usufruire di un servizio culturale devono recarsi in un centro commerciale, una multisala o un teatro sito in un quarto luogo. Che dire degli immigrati che non sono certamente una percentuale di abitanti dominante ma sicuramente non insignificante? E infine, solo per un accenno, a quale identità locale appartengono i ragazzi e le ragazze perennemente connessi con i loro smartphone? Allora le Unioni e ancora di più le Fusioni possono essere l’occasione per produrre progetti tesi a costruire una identità nuova, che riconosca qualifichi nuove centralità urbane o ne crei ex novo ridando all’ urbanistica un ruolo di ricucitura di una realtà tanto sfrangiata da favorire il sorgere di periferie anche in territori che nulla hanno a che vedere con le grandi città. E non mi si dica che il tema identitario si risolve inventandosi occasioni di rievocazione storica che nulla hanno a che vedere con la storia e che vedono contrapporsi contrade in costume e con stendardi che si rifanno ad un esercizio di pura fantasia. Spesso sono cose divertenti, qualche volta preoccupanti, sempre prive di qualsiasi capacità di costruire identità. Quindi lavorare sulla identità attraverso un dibattito che veda come cornice l’unione con altri comuni o la creazione di un nuovo comune è non solo necessario ma affascinante.
Democrazia. Quello che sta accadendo è drammatico. Alle ultime elezioni regionali i presidenti di regione eletti sono in vero stati legittimati da un 15/20% degli elettori aventi diritto al voto. Anche alle elezioni politiche il più grande partito è ormai quello del non voto. Questo prelude ad un deperimento della democrazia tanto grave da trasformarla potenzialmente nel volgere di poco tempo in oligarchia, il dominio dei pochi e potenti sui tanti “periferici”, disillusi quanto non disperati. Come ho detto all’inizio, la crisi della democrazia la sentimmo forte anche nei primi anni ’90 e la risposta della elezione diretta dei sindaci accompagnata da un accentuato ruolo delle autonomie fu una risposta efficace. Ora anche quel filo riannodato sembra spezzarsi. Io sono convinto che alla bassa tensione e partecipazione democratica che accompagna oggi anche la vita di molti comuni contribuisca non solo un clima generale ma anche una asimmetria che si va consolidando fra il luogo della rappresentanza politica, appunto il comune, e il luogo della organizzazione dei servizi (l’ambito sociale, la società partecipata, ecc.). Io voto per un mio rappresentante il quale non può più rispondere pienamente della organizzazione dei servizi che mi riguardano , allora cosa voto a fare? Allora ragionare su una Unione e ancora di più su una Fusione può essere un modo efficace per riconnettere i due aspetti della rappresentanza politica e del governo dei servizi, ricercando una dimensione ottimale che non risponda solo ad un ragionamento di efficienza, efficacia ed economicità dei servizi ma anche del possibile governo e controllo politico dei servizi medesimi. E’ del tutto evidente che a questo proposito la Fusione è più corrispondente al tema. Infatti con l’Unione il dualismo fra il luogo della rappresentanza e il luogo del governo dei servizi rimane ( io eleggo un consiglio comunale che poi nomina i propri rappresentanti nella Unione) mentre con la Fusione si tende a dare una risposta più netta in termini di corrispondenza diretta, anche se come abbiamo visto la dimensione dei nuovi comuni è talmente piccola che il problema spesso è solo parzialmente risolto in modo del tutto insufficiente.
Welfare. In un senso largo oggi tutti i servizi di prossimità che contribuiscono al benessere del cittadino sono sottoposti agli effetti devastanti del blocco delle assunzioni, delle minori risorse a disposizione, della domanda di maggiore professionalità, della introduzione di tecnologie avanzate adeguate. E’ del tutto evidente che davanti a noi c’è il tema di una profonda riorganizzazione dei servizi. Ma non c’è solo questo. C’è il tentativo di comprimere l’offerta di servizi e spesso si porta come argomento che la frammentazione degli stessi li rende economicamente insostenibili e siccome si accampano resistenze alla riorganizzazione da parte dei comuni li si lascia semplicemente deperire sotto la spinta di tagli lineari continui, oppure si tende a sottrarre ai comuni la titolarità dei servizi con lo stesso argomento. Allora una Unione o una Fusione diventa l’occasione per dare il senso vero al concetto di spending review, per ragionare sulla professionalizzazione dei servizi, impossibile quando questi sono frantumati in piccole entità, per proporre veri e propri piani regolatori dei servizi con una visione strategica dentro cui collocare anche il rapporto con il privato, con la cooperazione sociale, con il volontariato. Ma c’è di più. Una dimensione più ottimale della organizzazione dei servizi consente anche di mettere in campo anche quegli strumenti di controllo che sembrano essere stati il tallone d’Achille della recente stagione autonomista. I piccoli e piccolissimi comuni non possono realisticamente dotarsi di piani contro la corruzione, non possono esercitare quella rotazione di funzionari e dirigenti che è suggerita dall’ANAC, non possono avere un servizio di controllo di gestione e neppure un adeguato controllo da parte di un collegio di revisori dei conti. Saranno anche strumenti parziali ma è certo che al di fuori di una dimensione più vasta neppure questi si possono essere attivati.
Sostegno allo sviluppo. La crisi devastante che ha colpito l’occidente e l’Italia in particolare dal 2007 ad oggi ha fatto, o rischia di fare, piazza pulita di elaborazioni, progettualità che i comuni e le regioni avevano faticosamente costruito attorno ai distretti produttivi, al rapporto fra università e imprese, al sostegno ai processi di internazionalizzazione, alla costruzione di poli tecnologici avanzati. Si trattava di esperienze pionieristiche per ricavare un ruolo agli enti locali nelle politiche per lo sviluppo. La maggior parte dei comuni era infatti ancora ferma al governo dei processi con lo strumento dei prg ovvero preoccupati della localizzazione e dei servizi primari da offrire agli insediamenti industriali. Ora noi abbiamo intere aree industriali deserte, fra le imprese contiamo i “morti” e sulle punte delle dita delle mani i sopravvissuti. Eppure il tema è proprio per questo ancora più attuale. Ma se in una fase crescente poteva essere sufficiente per attrarre investimenti sul proprio territorio limitarsi ad offrire a buon mercato delle aree industriali attrezzate, oggi questo sarebbe ridicolo. Ci sono riconversioni da governare, processi di rinaturalizzazione, e sostegno alle imprese che tirano in particolare grazie alla domanda estera. E’ una partita che si gioca su una scala più grande rispetto a quella del singolo comune, ha a che fare con la ricerca scientifica, con le università più avanzate, con energie rinnovabili. Credo che rinunciare ad un ruolo dei comuni su tutto questo sarebbe mortale certo ci vuole un “fisico adeguato” e anche qui, unioni e fusioni possono provare a crearlo.
Ecco, credo che quanto detto sia sufficiente per rendere chiaro il mio pensiero: bisogna accelerare su Unioni e Fusioni dei Comuni per respingere l’attacco neo centralista e porsi in modo adeguato di fronte alle sfide nuove che i comuni devono affrontare. Per farlo non bisogna agire in emergenza o per solo calcolo economico ma mettersi al lavoro per inserire questo riordino istituzionale all’interno di percorsi di pianificazione strategica. Le modalità di redazione di questi piani sono sperimentate e hanno accompagnato anche casi di successo e non solo in Europa ma anche in Italia come la riconversione della città di Torino. L’Italia non è fatta solo di grandi città e la sperimentazione di piani strategici su scala territoriale è una strada a mio avviso necessaria.
Grazie per l’attenzione.
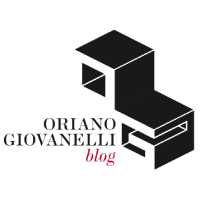

Leave A Comment