Parlamentarismo e autonomismo. La risposta al disegno istituzionale della destra.
Quale modello istituzionale si può intravedere dalle proposte di riforme della destra? Una riflessione che mi è stata chiesta da www.fuoricollana.it
Politica- 5 minuti lettura
Durante la campagna elettorale che portò alla vittoria della destra alle elezioni politiche del 25 settembre scorso, mi colpì molto l’atteggiamento che Giorgia Meloni tenne sulla questione del reddito di cittadinanza. Era del tutto evidente che, il suo netto e reiterato rifiuto ad aperture dialoganti su quella misura tesa a contenere il fenomeno della povertà e che, pur fra innegabili limiti e contraddizioni, aveva svolto un ruolo importante durate i duri anni della pandemia conquistando un largo consenso fra le frange più povere della popolazione, avrebbe dato un argomento formidabile al Movimento 5 stelle in particolare al Sud. Ricordo
che ne parlai più volte con un caro amico noto uomo di cultura certamente di destra. Anch’egli, romanticamente nostalgico della dimensione sociale della destra post fascista, si sorprendeva di tanta veemenza che a conti fatti avrebbe costato alla futura Presidente del Consiglio una maggioranza ben più larga in Parlamento e in particolare al Senato e, oso dire, quella maggioranza assoluta che le avrebbe spianato la strada per portare a termine riforme costituzionali tenendo fuori portata degli oppositori lo strumento del Referendum confermativo. Eppure una ratio in tanta apparente miopia c’era e c’è. La posta tanto agognata da Fratelli d’Italia era ed è il “controllo” della relazione stretta con i ceti economici più ricchi e influenti del Nord, con annessa la potenza di fuoco che questi poteri possono esercitare nel campo dell’ editoria, della comunicazione, delle banche. Perché è così che stanno anche storicamente le cose: la destra in tutte le sue declinazioni a partire da quella fascista è stata sempre prioritariamente tenuta per mano dalla destra economica del Nord, offrendo, nel contempo, allo scontento popolare dei surrogati di sicurezza e attenzione sociale. Bilanciata dal popolarismo democristiano nel dopoguerra, e contenuta dalla grande forza del Partito Comunista Italiano, la forza di quei ceti ha ripreso a muoversi in autonomia dopo il crollo dei grandi partiti costituzionali e, con una sostanziale coerenza, a fare politica. Prima con Forza Italia, poi con Forza Italia e la Lega nel Popolo della Libertà, ancora nella Lega di Salvini e con i governi tecnici di Monti e Draghi e ora in Fratelli d’Italia.
In questo Giorgia Meloni , che è davvero una leader non improvvisata della destra, senza farsi sedurre da velleità centriste, ha di fatto seguito le orme di Mussolini. E’ cresciuta nel consenso popolare cavalcando lo scontento da Nord a Sud, si è presentata con largo anticipo alle forze dirigenti del grande dominus americano e poi ha repentinamente svoltato verso una dimensione politica con il “doppiopetto”. Sta qui dentro la risposta alla domanda : ma qual’é il modello istituzionale che questa destra persegue? Qual’é la sua idea di Stato? La risposta a mio parere la si trova in un concetto: il modello che meglio asseconda i poteri economici più forti e corporativi con lo scopo di garantire loro: 1) una cosiddetta “democrazia decidente” 2) ” di non disturbare chi vuole fare”. Due principi che ritroviamo in bella e chiara evidenza nel discorso con cui la Presidente del Consiglio si è presentata alle Camere per riceverne la fiducia.
Due concetti che, dal punto di vista istituzionale, si traducono benissimo nel binomio Presidenzialismo/Autonomia differenziata, anch’esso esplicitato nel discorso alle Camere.
La direi così: il disegno istituzionale della destra, che ha vinto le elezioni il 25 settembre 2022, sarà quello che meglio si conformerà all’ idea di società della destra, al suo blocco sociale di riferimento. Se hai un modello sociale in testa puoi darti un progetto istituzionale, se non hai un modello sociale in testa finisci per vagheggiare riforme istituzionali che finiscono in nulla. E’ questo il macroscopico errore dei governi diversamente egemonizzati dal centro sinistra dal 2006 in poi: pensare che la propria adeguatezza a rappresentare l’Italia, oggettivamente mutata dal punto di vista della composizione sociale, del mercato del lavoro, delle relazioni internazionali ecc., potesse risiedere in una non-identità, nella rinuncia a farsi carico della rappresentanza di un blocco sociale in nome della trasversalità e della “vocazione maggioritaria”, nell’aver difeso retoricamente la Costituzione perorando, invece, nei fatti il primato del “vincolo esterno” sui contenuti sociali della Carta e lasciando progredire il logoramento degli equilibri fra i poteri nel senso di un ridimensionamento del ruolo del Parlamento, di un ruolo più forte del’Esecutivo e un ruolo più da protagonista del Presidente della Repubblica.
Nella nostra Costituzione un modello sociale c’è e coerentemente lo si può leggere tradotto, dal punto di vista istituzionale, in parlamentarismo e autonomismo. Ecco perché mi convince molto che la parola d’ordine della destra sarà ” de-costituzionalizzazione”. Ma quello che voglio sottolineare è il fatto che su quella strada la destra trova un terreno già arato dall’azione dei governi precedenti che comprendevano il centro sinistra negli ultimi venti anni.
E’ solo il caso di ricordare, senza pretesa di essere esaustivo, il susseguirsi di governi “del presidente”; la modifica dell’art.81 della Carta e l’abolizione delle province portata avanti in ossequio ad una lettera di una banca, sottolineo lettera di una banca, per quanto si chiami BCE; la rielezione del tutto anomala fatta passare come normale di Giorgio Napolitano e Sergio Mattarella; l’accettazione supina di un primato dei trattati europei, in alcuni casi chiaramente iper-liberisti e in palese contrasto con il carattere sociale della nostra Costituzione; il contenuto anti parlamentarista e anti autonomista della riforma costituzionale voluta dal governo di Matteo Renzi; l’abuso delle diverse forme di decretazione d’urgenza; fino alla svolta “pop” dell’attuale Presidente della Repubblica che non perde occasione per porsi in diretto dialogo con il popolo italiano quasi a controbilanciare la figura del Presidente del Consiglio in un dualismo che mette ai margini in modo sempre più drammatico la dialettica parlamentare e il ruolo delle forze politiche.
Voglio dire che come accade sulla questione della pace , se si smette di rivendicare il suo primato così solennemente affermato in quel “ripudia la guerra” dell’art.11 della Costituzione, va a finire che ci si trova di fatto in guerra senza che questo susciti il minimo dibattito. Così pure se si smette di affermare il carattere parlamentare della nostra Repubblica finisce che ci si ritrovi di fatto in un contesto più affine ad una forma presidenzialista senza averne discusso e senza averne potuto regolare la natura con i relativi contrappesi. Proprio a causa di questo vissuto, io non credo che ci troveremo davanti a particolari forzature da parte del Governo Meloni tali da farci gridare al colpo di mano. No. Semmai è il caso seguire, in questa fase, la sistematicità con la quale la Presidente del Consiglio cercherà di prendere il controllo delle diverse “casematte” ( Gramsci è molto studiato nei movimenti giovanili di destra) che sostanziano il potere romano. Quindi l’attenzione sarà sulla discontinuità nel governo delle grandi aziende in vario modo partecipate dallo Stato (esercizio mai portato avanti davvero dalla sinistra), dal controllo sulla magistratura, i media, la cultura ecc. Solo quando il percorso risulterà maturo, sarà sufficiente seguire il solco tracciato dalle confuse velleità riformatrici dei governi di centro sinistra e porre la domanda: vogliamo andare avanti in questo modo confuso o vogliamo formalizzare ciò che è già in essere? La mia previsione è che molte teste pensanti del centro sinistra si metteranno a disposizione per una sistemazione “pacifica” semi presidenziale della nostra Repubblica, in caso contrario si continuerà ad andare avanti così con piccole forzature quotidiane apparentemente dettate dallo stato di necessità. Mi torna in mente quel prezioso volume di Guido Melis, “la macchina imperfetta” ( il Mulino ) in cui, analizzando la modalità seguita da Mussolini per impossessarsi della macchina dello Stato, egli ci ricorda che non furono necessari particolari strappi con lo Statuto Albertino in virtù delle cui norme egli era arrivato al potere nel pieno rispetto della legalità formale. Bastò, almeno fino al 1926, fare piccole forzature, piegare la resistenza dei prefetti, acquisire l’accondiscendenza della magistratura ( singolare come emerga da quel libro che fu il compito più semplice per Mussolini) e, quando le strutture ministeriali non seguivano ordinatamente le nuove aspettative del Presidente del Consiglio, accentrare a se e aggirare le burocrazie statali con strutture parallele. Fu sufficiente, da un lato, avere un Parlamento ridotto al mutismo e quando questo non poté verificarsi sappiamo come andò; dall’altro cancellare ogni parvenza di autonomia locale. Ora Meloni non è Mussolini e non voglio in nessun modo mettere in dubbio la sua volontà di emanciparsi da quella storia, il nostro Parlamento, pur non godendo di buona salute, ha margini per farsi sentire, il nostro Presidente della Repubblica non è Vittorio Emanuele III e soprattutto la nostra Costituzione non è lo Statuto Albertino. Ma questo è il primo governo di destra autentica della storia repubblicana e io un pensierino a quella vicenda lo terrei sempre attivo.
Qualcuno può pensare che in questo scenario l’autonomia differenziata, come è stata definita nel disegno di legge di attuazione dell’art.116 terzo comma della Costituzione proposto dal ministro Roberto Calderoli, sia una forzatura che stride con l’approccio che la Presidente del Consiglio cerca di tenere e in contraddizione con il suo progetto presidenzialista. Effettivamente l’ illustrazione in parallelo di queste due volontà come fatta nel discorso di Meloni alle Camere sa più di politicismo verbale per tenere assieme due cose contrastanti che di qualcosa di meditato. Però credo che lo sia solo in parte. Non c’è dubbio che l’autonomia differenziata è un progetto che Meloni si deve far piacere per puro calcolo politico ( soprattutto a Meloni non piace la fretta su queste questioni) considerato che è un punto su cui uno dei suoi alleati non è disposto a cedere. Ma c’è anche un calcolo di altro tipo. lo chiamerei il modello corporativo 2.0; una prova d’amore verso quei poteri economici forti del Nord di cui ho scritto sopra e che rimangono l’obiettivo più importante per Fratelli d’Italia cui è dedicata la frase chiave di tutto il discorso alle Camere: …E allora il nostro motto sarà ” non disturbare chi vuole fare”. Non dimentichiamo che quella comunità ricca e laboriosa, che con Aldo Bonomi abbiamo imparato a conoscere e a studiare, non è certo ancora guarita da quel “rancore” verso Roma matrigna e sprecona che ha maturato nei decenni scorsi. E’ troppo presto per costoro per fidarsi del tutto dei nuovi capi, meglio tenersi un margine di autonomia rassicurante e Meloni glielo da.
Ecco perché a mio parere in questo dibattito sulle riforme istituzionali ci sono dei paletti che vanno messi subito e con grande chiarezza in modo tale che si possa lavorare per creare attorno ad essi una contro narrazione rispetto a quella che ad oggi sembra essere dominante. Bisogna farlo sapendo che sarà un percorso in salita perché se fa presa la narrazione avversa vuol dire che essa ha messo radici su problemi reali che andranno analizzati e su cui sarà necessario avere delle risposte soddisfacenti. A mio avviso questi paletti sono essenzialmente due: parlamentarismo e autonomismo da contrapporre a presidenzialismo e autonomia differenziata. Per essere credibili l’approccio deve essere intelligente, ovvero non nascondersi dietro a questioni di principio per non affrontare problemi reali che esistono. Non possiamo nasconderci il fatto che le migliori stagioni del parlamentarismo italiano coincidono con la stagione dei partiti, dei grandi partiti popolari e di massa e di quelli anche più piccoli ma capaci di una visione e una elaborazione importante sui temi del paese. E’ pensabile un rilancio del parlamentarismo senza mettere seriamente le mani ai partiti politici? Io credo di no e parlo dell’art.49 della Costituzione, del finanziamento pubblico dei partiti, di una azione di ri-legittimazione del confronto fra i partiti come sale di una autentica democrazia, possibile solo se matura una reciproca capacità di riconoscersi come funzionali ad un più generale interesse nazionale. Così pure è difficile pensare ad un parlamentarismo forte se chi siede in Parlamento rappresenta un elettorato sempre più ristretto a causa del debordante astensionismo , complici certamente delle pessime leggi elettorali ma anche un approccio culturale demenziale che sostanzialmente ha ritenuto quel fenomeno come insito nel carattere maturo della democrazia, nella fine del confronto ideologico salutato come un grande fatto positivo; quante volte ho sentito dire : l’astensionismo non è un problema, in America è così da decenni. Infatti in America abbiamo avuto e potremmo riavere Trump e l’assalto a Capitol Hill. Infine, ma solo per brevità, i sostenitori del parlamentarismo devono farsi carico della efficacia del ruolo del Parlamento, la produttività del lavoro delle commissioni, la qualità delle leggi, i tempi di decisione. Questo potrebbe portarci ad affrontare il tema di un monocameralismo che oggi sarebbe motivato anche dal consistente taglio del numero dei parlamentari. Una analoga riflessione di merito s’impone anche sul versante dell’autonomismo. Molti detrattori dell’autonomismo, che onestamente dimostrano di studiare poco, concentrano il loro fuoco sulla riforma del Titolo V della seconda parte della Costituzione approvata nel 2001. Poi portano ad esempio i presunti venti sistemi sanitari regionali dimenticando che la competenza delle Regioni in sanità è antecedente la riforma del Titolo V. Come non vedere gli squilibri che vi sono nel paese proprio in merito al servizio sanitario! Ma davvero qualcuno pensa che siano il frutto del Titolo V? O non erano preesistenti? O hanno radici in leggi nazionali come quelle che hanno favorito la sanità privata convenzionata, o ancora il fenomeno dell’intramoenia che , nato con buone intenzioni, ha fatto sì che per le visite specialistiche gratuite si debba attendere mesi mentre con lo stesso professore, nella stessa sede ospedaliera, pagando il tempo d’attesa si riduce a giorni? E non è forse una legge nazionale che ha creato le aziende sanitarie? Anche qui con lo scopo apparentemente sano di sollevare la gestione sanitaria dalle interferenze politiche ( ricordo come fosse un tema molto caro al compianto Giovanni Berlinguer), salvo poi che con l’attribuzione di un valore economico alle prestazioni, è diventato “dominante” il sistema dei DRG finendo per contribuire a squilibrare il sistema dal territorio verso ospedali iper-specialistici, cosa che in alcuni territori ci ha fatto trovare disarmati di fronte alla pandemia. Per non parlare del progressivo tagli al finanziamento pubblico del sistema. Se si vuole parlare di sanità lo si faccia davvero e seriamente ma accodarsi ad una narrazione di comodo finirà solo per favorire lo smantellamento della sanità pubblica e gli interessi economici enormi che ruotano attorno alla sanità. Altri contribuiscono alla narrazione ostile alle autonomie locali portando avanti il tema delle complicazioni nell’ottenere autorizzazioni per i grandi impianti e reti di valore nazionale e via dicendo. Poi vai a scavare e ti accorgi che molti di questi presunti ostacoli, dico presunti perché spesso sono alert su problemi reali, vengono dalle soprintendenze statali, oppure dal cattivo funzionamento delle conferenze dei servizi che sono regolate da leggi statali. Quello che mi preme non è nascondere i problemi reali di funzionamento del sistema istituzionale ma rigettare una narrazione che porta acqua, consapevolmente o meno, ad un centralismo statale del tutto coerente con il disegno della destra. Dimenticando che quel centralismo alla fin fine sarebbe in mano alle burocrazie ministeriali, ovvero la vera tomba per un sistema pubblico che funzioni davvero, oppure, ancora peggio, porterebbe all’ “appalto” di pezzi di statualità a grandi aziende private ( ex pubbliche) per funzioni e servizi di primaria importanza per l’esigibilità dei diritti di cittadinanza e anche questo sarebbe un bel regalo al progetto della destra. Senza dire che si finirebbe per deresponsabilizzare ancora di più le classi dirigenti diffuse del Paese e allontanare i cittadini da una idea di cittadinanza attiva e consapevole. Andrebbe ricordato che molti diritti di cittadinanza hanno avuto le migliori stagioni e spesso sono state frutto delle migliori esperienze nate nelle autonomie locali e solo dopo diventate politiche nazionali. E anche oggi accade su molti temi come la spinosa questione dei migranti oppure sulla gestione di beni comuni ecc. Ma per vincere questi pregiudizi che spesso nascondono interessi economici enormi, la cultura autonomista si deve interrogare e dirsi chiaramente cosa intende fare. Certamente bisogna dire NO al progetto di autonomia differenziata presentata dal ministro Calderoli e approvato dal Governo. Le ragioni sono tante e a mio parere riguardano una lettura approfondita, anche da parte della Corte Costituzionale, di ciò che realmente sia possibile fare con il terzo comma dell’art.116. Io penso ad esempio che l’attuazione di quel comma non possa significare in alcun modo che sulle funzioni aggiuntive attribuite alle regioni tramite l’intesa finisca, in alcuni casi, la competenza esclusiva dello Stato e negli altri la competenza concorrente. Ma i nodi più sostanziosi di quel disegno riguardano le risorse finanziarie. La dico così seccamente: non è possibile agire sul terzo comma dell’art.116, nel modo così radicale che viene proposto, se non si da piena attuazione all’art.119 della Costituzione che attiene a tutta l’autonomia finanziaria degli enti locali e al disegno perequativo teso a colmare gli squilibri nella capacità fiscale dei diversi territori. Ma anche dal punto di vista di una stretta visione autonomista quel progetto è pericoloso, un centralismo regionale già alimentato dalla sciagurata scelta operata sulle province, si muoverebbe, se non corretto, in controtendenza rispetto al principio di sussidiarietà definito nell’art. 118 della Costituzione. Detto questo, la controproposta al disegno della destra non può limitarsi ad un No. E’ urgente in parallelo ad un lavoro sul parlamentarismo rilanciare una riflessione di sistema sull’autonomismo. Paradossalmente la riforma del Titolo V della seconda parte della Costituzione, che doveva segnare la sistematizzazione di un percorso che si era dipanato negli anni 90 del secolo scorso dalla approvazione della legge 142/90 in poi, ha segnato, invece, l’avvio di una controriforma del sistema delle autonomie locali. Il culmine si è verificato con il tentativo di abolire in costituzione le Province. Un tentativo fallito con la bocciatura della riforma costituzionale voluta da Matteo Renzi, assieme alla sua proposta di riportare al centro gran parte delle materie di competenza concorrente previste nell’art.117. Ma nella sostanza le Province sono state svuotate e ne sentiamo oggi la mancanza per tanti aspetti e in particolare per l’attuazione delle misure previste dal PNRR. Per quel grande progetto si è scelto di puntare sui comuni, ma sono pochi i comuni davvero attrezzati per reggere quel compito e con le Province avremmo potuto, come è sempre avvenuto in passato, supportare quelli più piccoli che sono la gran parte dei nostri 8000 comuni. E l’attacco alle province era stato ampiamente preceduto dall’attacco portato con successo ai Consigli di Circoscrizione delle città sotto i 250000 abitanti, alle Comunità Montane che, con tutti i loro limiti, erano comunque forme di aggregazione funzionale dei comuni polvere che troviamo nelle nostre aree interne. Ma l’attacco più letale alle autonomie è stato condotto con la drastica riduzione della autonomia fiscale e finanziaria e con il patto di stabilità interno. E’ in quel modo che si sono erose le capacità proprie degli enti locali di finanziarsi e di gestire le loro risorse umane e finanziarie. Senza autonomia finanziaria e organizzativa gli enti locali tornano a dipendere in tutto e per tutto dal governo centrale , dai trasferimenti, dalle compensazioni sui tagli decisi dalle annuali leggi di bilancio che si sono susseguite. L’effetto è stato deleterio non solo perché svilito la capacità operativa degli enti locali ma ne ha lesionato il concetto di responsabilità su cui si era cominciato faticosamente a lavorare. Se gli enti locali tornano ad essere solo dei terminali di spesa è tutto il Paese che ci perde. Per me il passaggio chiave per la crescita di una classe dirigente locale non sta, tanto e non solo, nel conquistarsi dei finanziamenti da Roma e dimostrare di saperli spendere, ma sta nel saper riscuotere le imposte dai propri concittadini per dover poi rendicontare a loro come vengono utilizzati. E’ su questo punto che dopo il 2001 i governi, tutti nessuno escluso hanno lesionato l’autonomismo.
Parlamentarismo e autonomismo sono quindi a mio parere la risposta al disegno della destra. Entrambi questi capisaldi si rifanno a logiche di sistema , al dialogo fra diversi livelli istituzionali e fra le forze politiche, alla concertazione fra le istituzioni e i corpi sociali, al compromesso per la soluzione dei
14
conflitti nell’interesse dei cittadini e del paese. Ma soprattutto sono sistemi, e la nostra Costituzione ne emana chiaramente lo spirito, che rafforzano il legame di appartenenza alla comunità, alla nazione intera, che si rinnova continuamente con la partecipazione; senza negare questo sentimento in nome di vincoli esterni alla nazione, né delegandolo a sistemi carismatici che, nella apparente semplificazione decisionista, riconducono ad un potere dei singoli o di oligarchie. Mi guardo intorno, vedo le aride tendenze dominanti nelle democrazie cosiddette avanzate e mi rendo conto di quanto sia difficile rovesciarne la deriva. Ma va fatto ciò che è necessario.
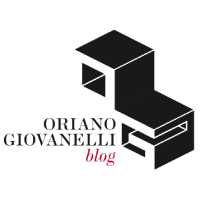

Leave A Comment