1 Circa trent’anni fa debuttava alle elezioni europee un movimento denominato Lega Lombarda- Alleanza per il Nord che riportò un risultato modesto: l’1,8%. Ma non era altro che la punta di un iceberg, mai troppo preso sul serio, verso il quale stava andando il Titanic della politica romanocentrica.
Quel movimento appena pochi mesi dopo diventava un partito. A dicembre dello stesso anno infatti nasceva la Lega Nord con la fusione di Lega lombarda, Liga Veneta, Piemont Autonomista, Union Ligure, Lega Emiliano Romagnola, Alleanza Toscana.
Per la prima volta nella storia repubblicana un movimento che spingeva l’autonomismo fino alle soglie della secessione non aveva una radice storico-linguistica o dovuta a specifiche condizioni geografiche di confine. No, la sua radice era l’economia, l’impresa, il mondo del lavoro contadino e operaio in rapporto ad una politica sempre più lontana, a partiti asimettrici rispetto alla realtà sociale, ai costi competitivi di questa lontananza per la parte più ricca e produttiva del paese.
Quell’1,8% si rivelerà il primo vero seme di una politica che si stava liberando dello schema comunismo/anticomunismo per entrare in una dimensione tutto sommato più europea, perché a prescindere da quello che oggi dice Salvini contro l’Europa, il potenziale della Lega Nord di allora era tutto nel timore di quella parte di paese di perdere il treno di una Europa che per imprese, fisco, pubblica amministrazione, assetto istituzionale sembrava essere molto più in grado di reggere il passo incalzante della globalizzazione rispetto alla burocratica, clientelare e corrotta Italia di fine anni ottanta.
Infatti La lega Nord fu quella più pronta a raccogliere i frutti di quei cambiamenti in atto. Già nelle amministrative del 1990 sfondava in Lombardia con il 18,9% e diventava il secondo partito dopo la DC, battendo il PCI in piena crisi con il suo elettorato popolare che si fermava al 18,6%, e conquistando centinaia di consiglieri comunali.
Quando D’Alema farà la battuta su la Lega come costola della sinistra solo chi era in malafede poté far finta di non capire che la radice dell’elettorato della Lega Nord era molto contiguo a quella dell’elettorato popolare che il PCI stava perdendo. Niente a confronto con la capacità della Lega Nord di fagocitare, di li a poco tempo, l’elettorato democristiano in libera uscita dal fallimento della DC travolta da tangentopoli e dalla fine del collante anticomunista.
Alle elezioni politiche del 1992 infatti la Lega Nord prende l’8,6% su scala nazionale, 80 parlamentari e sfonda al Nord.
Ora, 26 anni dopo, alle elezioni del prossimo 4 marzo per la prima volta non ci sarà il simbolo Lega Nord Padania ma un logo Lega-Salvini premier.
Cosa c’è dietro a questo cambiamento ( liberi di pensare che sia una evoluzione o una involuzione)? In sostanza c’è un fatto molto rilevante e anche questa volta di respiro europeo. Per usare le categorie della riflessione che Aldo Bonomi ha messo a fuoco già da diversi anni: la comunità laboriosa si va saldando con la comunità del rancore. Siccome il rancore è una merce che si vende bene ad ogni latitudine di ogni paese europeo, l’idea di Salvini è di fare della Lega Nord una Lega Nazionale del Rancore che ovviamente cerca come primo interlocutore sociale “la comunità laboriosa”. Lo scenario non è più non perdere il treno della globalizzazione galoppante degli anni 80/90, ma sfruttare le paure prodotte dal rinculo della globalizzazione.
Credo che si tratti di un calcolo errato da parte di Salvini, una scelta di corto respiro e l’aver lasciato cadere la bandiera del federalismo sarà per lui come aver bruciato i ponti alle spalle, quei ponti che sono risultati molto utili alla Lega Nord in una storia decennale di un partito che ha conosciuto molti alti ma anche numerosi bassi.
2 Ora il punto è chi prende in mano la bandiera del federalismo/autonomismo? E’ una bandiera ancora importante nello scenario nazionale ed europeo o è davvero un vecchio panno logoro e sfilacciato e ormai inservibile?
L’autonomismo e ancora di più il federalismo va d’accordo con concretezza, autogoverno, filiera corta delle relazioni umane e sociali, cura, capacità di farsi carico delle soluzioni dei problemi più che della loro denuncia; fa il paio con riformismo e non con populismo, parla più il linguaggio comunitario di Olivetti o di Bassetti che il linguaggio statalista di una vecchia sinistra o iperliberista della destra dedita alla speculazione finanziaria; è la base su cui costruire una economia circolare, una economia della condivisione più che una economia predatoria e dello scarto.
L’autonomismo non è privo di contraddizioni, può scivolare sull’isolazionismo, sulle identità chiuse. Ma è il terreno dove può radicarsi la grande idea del pensare globale e agire locale, dove la globalizzazione può essere assimilata senza smarrimenti, senza tagliare le radici, senza spersonalizzazione e omologazione culturale. Cosa è diventata certa élite di sinistra, quando non si è venduta del tutto al pensiero unico liberista, se non un pensiero senza popolo, un biglietto di volo perenne, una comunità dedita al predicozzo sui diritti individuali ma che non vede la miseria nelle periferie attigue ai propri quartieri.
Troppo faticoso per certa politica pensare in grande all’altezza degli occhi della gente.
Solo una nuova sinistra può prendere in mano quella bandiera. Solo la sinistra che ha nel suo DNA una visione internazionale dei processi può rendersi conto di quanto siano davvero in crisi gli stati nazionali nati dopo la prima guerra mondiale e consolidati con la seconda e nello stesso tempo rifuggire da derive identitarie. Solo la sinistra che ha letto il Manifesto di Ventotene può far sua l’idea che la risposta a questa crisi è una Europa politica e sociale. Solo la sinistra che ha fatto tutti i conti con il “comunismo burocratico” può rifuggire dallo statalismo che fa rima con nazionalismo e mettere a frutto una cultura dei beni comuni e di un mercato regolato. Solo la sinistra che conosce i distretti produttivi può arginare la svendita di un patrimonio manifatturiero di grande qualità stando vicino alle piccole e medie imprese e non amoreggiando con le multinazionali.
Adesso c’è il 4 marzo, ma all’ordine del giorno del 5 marzo c’è la ricostruzione della sinistra. Le elezioni sono un passaggio non la meta. Per tante ragioni non posso che prenderla sul serio questa ambizione. Ma la sinistra riformista per rinascere davvero dovrà ridare voce a chi oggi non ne ha: i diritti del lavoro e le comunità in carne e ossa lontane dalle élite romane. Tutti oggi pascolano lo stesso terreno: il rapporto con le lobbies più potenti, le multinazionali, un nazionalismo di ritorno, patti con le alte burocrazie inamovibili e al popolo viene riservato il predicozzo sulla flessibilità, e si tenta di ammansirlo con i bonus. C’è ne sono tanti che si è perso il conto! C’è una piramide da rovesciare. Guardate il valzer delle nomine, o ancora i provvedimenti che vanno davvero a colpire i poteri forti, le rendite, i patrimoni: una Italia che tutti vogliono cambiare ma che è sempre uguale a se stessa. Scala sociale bloccata, generazioni di giovani perdute. Si potrebbero fare tantissimi esempi. Allora la sinistra popolare e riformista o ripartirà dal basso o non nascerà, non potrà radicarsi. Il fatto che la “Lega-Salvini premier” abbia abbandonato la bandiera del federalismo toglie di mezzo un equivoco, una distorsione, una lettura sbagliata di un problema vero: Europa federale, Italia federale, autonomie. Ci pensi la sinistra a raddrizzare quella bandiera perché non è mai stata tanto necessaria e moderna.
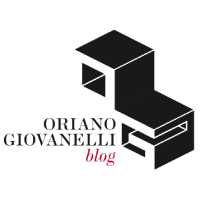

Leave A Comment